Stoicismo.
- Pierluigi Casolari
- 5 apr 2024
- Tempo di lettura: 9 min
Per lo stoicismo nutro grande ammirazione, e in alcune aree della mia vita cerco di praticarlo. Lo stoicismo è stata la grande occasione mancata della filosofia occidentale. Quando nacque nel quarto secolo prima di Cristo, lo stoicismo riprese la componente pratica e maieutica di Socrate che intendeva la filosofia come medicina dell'anima. I filosofi stoici ci hanno lasciato spunti straordinari per intendere la vita come pratica di vita. Purtroppo però la filosofia successiva non ha colto questo spunto. La via aristotelica della filosofia come scienza e conoscenza ha preso il sopravvento sulla filosofia come guida alla vita, saggezza pratica, esercizio e insegnamento della virtù. Salvo qualche esempio straordinario come quello dell'imperatore romano Marco Aurelio che ha portato lo stoicismo nelle istituzioni romane e dopo di lui hanno fatto altri stoici come Seneca che sono stati precettori e maestri di nobili, senatori e altri imperatori, questa corrente filosofica è stata dimenticata per oltre 2000 anni dalla filosofia. Filosofia che si è chiusa gradualmente nel proprio ghetto accademico, divenendo prima scienza, e poi dopo che la scienza ha preso le distanze da ogni pensiero metafisico, è divenuta discorso marginale intorno a problemi formali, verbali, linguistici. Oppure astruso sapienza esistenziale. E' il caso di Heidegger che pur riavvicinandola ai temi riguardanti la vita l'ha resa ancora più astrusa, marginale e vacua. Contradditoria persino per lui stesso: prova ne è che Martin Heidegger il filosofo dell'uomo, dell'umano, della tragedia del vivere ha aderito senza pensarci due volte al nazismo, cacciando dall'università di cui era rettore i suoi maestri ebrei.
Ad ogni modo lo stoicismo come filosofia pratica è uscita di scena, fino a quando lo psichiatra Paul Dubois fonda nei primi anni del novecento la scuola di psicoterapia di persuasione razionale che si ispirava agli stoici e poi dopo di lui negli anni cinquanta il movimento della scuola di psicologia cognitiva inserisce tra i propri presupposti teorici proprio lo stoicismo. Ai cognitivisti dello stoicismo piaceva la monumentale e liberatoria nozione per cui bisogna sempre separare i fatti dalla loro interpretazione. Ovvero separare quello che ci succede dal modo in cui possiamo interpretarlo. Secondo questa corrente i problemi emotivi sono in gran parte legati ad interpretazioni scorrette e disfunzionali dei fatti. Il grande revival dello stoicismo soprattutto in questi ultimi anni nasce da questa monumentale acquisizione: non siamo quello che ci succede, non siamo i fatti e le disgrazie che ci possono capitare, ma è sempre possibile modificare l'interpretazione di quello che ci succede. Amor fati, diceva Marco Aurelio. L'amore per il destino per quello che ci accade, qualunque cosa sia: The obstacle is the way, ogni ostacolo è un insegnamento scrive Ryan Holiday, scrittore e autore americano che più di qualunque altro sta portando alle masse lo stoicismo.
Come segnala Michele Putrino, autore del canale Scuola Stoica Italiana in questa bella intervista lo stoicismo non è solo questo è anche disciplina ed è anche ritorno alla natura. Putrino collega lo stoicismo della resilienza - reagire in maniera intelligente alle situazioni avverse - allo stoicismo romano - autodisciplina., fortezza d'animo, vivere secondo natura. Che cos'è per lo stoicismo questo vivere secondo natura? La natura dell'uomo è duplice secondo gli stoici, è razionale ed è sociale. Vivere secondo natura significa dunque vivere con le persone e per le persone. A differenza dei cinici, gli stoici erano nel sistema, non erano contro il sistema. Non erano paladini del sistema, ma erano fedeli al proprio ruolo e compito sociale. Ed esercitavano la razione, il pensiero. In questo esercizio manifestavano pienamente la propria umanità. Ma non si trattava di filosofeggiare sui massimi sistemi, il pensiero era un esercizio spirituale, non dottrina, non accademia, come fanno oggi i nostri filosofi da salotto. La vita - la propria vita, non quella degli altri - era il libro su cui studiare ed esercitare il pensiero critico. Gli stoici ci hanno lasciato spunti, esercizi, per vivere secondo filosofia, ovvero secondo natura, ovvero in società e razionalmente. Su questo punto torneremo.
Nella vita, lo stoico si abitua a distinguere il fatto dalle sue interpretazione, nella vita lo stoico impara l'arte di usare la ragione per governare le emozioni, nella vita lo stoico impara la disciplina accettando la durezza della realtà, ridandosi continuamente nuove motivazioni per vivere in maniera dignitosa.
Ci sarebbero un'infinità di cose da dire sullo stoicismo. Per me lo stoicismo è prima di tutto la grande occasione mancata della filosofia occidentale per liberarsi dal filosofeggiare vuoto da salotto. Occasione mancata per duemila anni, ma chissà forse nei prossimi anni verrà colta, almeno in parte.
Lo stoicismo potrebbe essere la risposta occidentale al bisogno di risveglio spirituale. La mia stima per lo stoicismo è enorme. Penso anche che ognuno di noi, dovrebbe esercitarsi su alcuni dei capisaldi stoici. Lo stoicismo è un ostacolo importante all'irrazionalismo di buona parte della spiritualità new age e new wave che considera la mente il problema della nostra vita. Lo stoicismo ci aiuta invece a portare il pensiero razionale all'interno della vita, animato da un forte senso di comunanza con gli altri e dal principio della responsabilità. Le potenzialità dello stoicismo sono immani, vorrei però segnalare alcuni punti di debolezza e spiegare dunque perchè lo stoicismo non può essere adottato come unica filosofia di vita - ma può certamente essere parte di un'ecologia di pratiche esistenziali e di crescita spirituale.
Durezza. Nello stoicismo si percepisce una certa durezza. Marco Aurelio diceva sempre: compassionevoli con gli altri, duri con sé stessi. Il punto è che questo non funziona. Lo hanno dimostrato decenni di psicologia. La durezza con sé stessi, l'autodisciplina ferrea è solo uno dei fattori per la motivazione, la crescita, la capacità di affrontare le difficoltà. Se non è temperato da una strategia di autocompassione, questa durezza porta alla autodistruzione. Vi ricordate la scena di American Beauty, quando la moglie del protagonista, ascolta l'audio del coach che la motiva: "disciplina, motivazione" dice la voce fuori campo. "se vuoi avere successo devi costruire un'immagine di successo. Lei poi inizia a piangere e con un dialogo interiore furioso si sgrida impietosamente urlandosi contro: "non piangere, non essere stupida".
Ecco questo è l'altro volto della disciplina ferrea. Non funziona, ad un certo punto, semplicemente non funziona più. il meccanismo diventa autodistruttivo. Noi però disponiamo di un sistema calmante che a livello ormonale è basato sull'ossitocina e che a livello psicologico è basato sulla capacità di essere compassionevoli con sé stessi, la capacità di ammorbidire. "Cominciamo a cambiare solo quando accettiamo come siamo, scrisse Carl Rogers, il fondatore del counseling. Questo elemento manca nello stoicismo e sostanzialmente si tratta di un grave limite. Gli stoici non potevano saperlo, ma oggi lo sappiamo. Non possiamo essere compassionevoli con gli altri, ma duri con noi stessi. Dobbiamo essere compassionevoli sempre. Punto.
Assenza dei livello sottili e spirituali. Lo stoicismo non è una forma di ateismo, Il principio spirituale per gli stoici esiste ed è la natura stessa e la natura stessa non è altro che la ragione, la razionalità, il principio d'ordine che governa tutto. Il punto è che nello stoicismo manca completamente un principio che invece permea le tradizioni orientali: lo spirito. Lo spirito non è razionalità, non è il pensiero che pensa, ma è la consapevolezza che tutto include, all'interno di cui tutto esiste. Per dirla come la direbbe Ken Wilber: noi non siamo i fatti, ma non siamo neanche l'interpretazione, noi siamo la consapevolezza in cui tutto accade, anche i fatti e anche le loro interpretazioni.
Insieme alla consapevolezza, nello stoicismo manca anche una comprensione dei livelli sottili dell'esperienza, che non sono emozioni e che allo stesso tempo non sono ragione. I chakra, la Kundalini, i meridiani, le energie sottili che i praticanti di Yoga, meditazione vivono nel proprio corpo come presenze ovvie e dimensioni che indirizzano le nostre emozioni e i nostri pensieri, nello stoicismo semplicemente non esistono. Questo è un tema di tutta la filosofia greca. Il logos non è un chakra, in effetti. Il logos, la ragione, il ragionamento è il perno di tutto il pensiero greco. Il logos ci porta spesso lontano dalla vita, come sa chiunque pratichi la meditazione. Il logos, il ragionamento è uno strumento importante, ma deve essere integrato all'interno di un sistema che tiene conto di molte altre facoltà, superiori al logos stesso. Socrate il genio della filosofia aveva capito questo e proprio per questa ragione non scrisse libri, non lasciò nulla di scritto. La filosofia per lui era basata su un logos dialogico, che doveva portare all'aporia, al disorientamento cognitivo, grazie a cui si poteva creare lo spazio per nuove verità, tra cui quelle provenienti dalla voce interiore del daemon, il demone, che la filosofia successiva ha volutamente dimenticato. Che cosa intendesse con questo daemon Socrate non si sa ancora, probabilmente il daemon era una voce interiore, oppure le intuizioni che Socrate aveva durante gli stati contemplatici e meditativi a cui si abbandonava per ore e giorni in modo continuativo. Socrate non ha praticato la meditazione in senso tradizionale, ma si isolava spesso dal gruppo ed entrava in stati di assorbimento che in base a quello che ci è stato riportato ricordano da vicino gli stati di samadhi e jhanici degli yogi. Il collegamento tra questi stati, la sua filosofia dialogica, il daemon, la sua grande forza d'animo, la vocazione per la giustizia fino al sacrificio di sè stesso, fanno di Socrate l'altro straordinario maestro di un nuovo tipo di filosofia pratica, che va persino oltre il punto raggiunto dagli stoici.
Esercizi Spirituali vs pratiche meditative. Il teologo Vito Mancuso scrive che Buddha ha fatto un grande dono all'umanità e questo dono non sono le 4 verità, gli 8 passi dell'ottuplice sentiero, i 4 fattori dell'illuminazione, i 5 precetti - Buddha, si vede, amava le liste e oggi sarebbe un content marketer pazzesco - no, il grande dono di Siddharta all'umanità è stata la meditazione. Seduta sotto l'albero della Bodhi, e determinato a non alzarsi fino a quando non avesse raggiunto l'illuminazione, assorto nella ricerca della via per liberare l'umanità dalla sofferenza, dopo giorni e giorni di immobilità, sofferenza e trascendenza della propria umanità, Siddharta si ricordò di un ragazzo che aveva incontrato al fiume, che suonava il liuto. "Non troppo tese, non troppo lente" per suonare bene, le corde non devono essere troppo tese, gli aveva detto quel ragazzo, pechè altrimenti potrebbero rompersi, ma neanche troppo lente, altrimenti non emettono alcun suono. Ecco la via della meditazione. Siddharta se ne ricordò e a quel punto tutto cominciò a prendere forma, Gli antichi saggi bramini avevano elaborato delle forme di meditazione, psicotecniche per fermare la mente, fermare i pensieri. Ma quando interrompevano le loro meditazioni ascetiche, tutto tornava come prima. Siddharta invece voleva fermare la sofferenza non per il tempo della meditazione ma per sempre. La via dei bramini e degli induisti era troppo dura - era una forma di stoicismo spirituale. Non si trattava di cancellare i pensieri, ma di osservarli. Era quello il trucco. Not too tight, not too loose. Se i pensieri li osservo, allora pian piano accedo ad una dimensione che non è il pensiero, non è la ragione, ma è la consapevolezza che tutto include, anche i pensieri, il mondo, le sensazioni, gli oggetti che vanno e vengono. Grazie a questo Osservatore impersonale osservo l'impermanenza dei pensieri e delle sensazioni e così face Buddha, il risvegliato, in quei 40 giorni sotto la Bodhi esercitò l'arte della meditazione - inventando e praticando la meditazione Vipassana, la visione profonda che permette alla nostra consapevolezza di osservare: l'impermanenza di ogni cosa, l'assenza di un sé personale, l'interdipendenza di ogni cosa. Al termine di questo lungo ritiro - il primo e più lungo ritiro di Vipassana - Siddharta si risvegliò e divenne il Buddha. Oggi la meditazione è praticata da milioni di persone, pochi dei quali raggiungono l'illuminazione, ma molti praticanti, quasi tutti ricevono in dono i benefici del praticare, grazie alla irripetibile umanità di Siddharta - quando penso a questa storia, mi viene in mente quella contemporanea di Openheimer, che si rinchiuse insieme ad altri ingegneri in una sorta di città fantasma, e si decise che non ne sarebbe mai venuto fuori fino a quando non avessi inventato la bomba atomica. Era un dono anche questo, ma un dono che non ha portato benefici. Al contrario della meditazione, che come dice il Dalai Lama se tutti praticassero, in capo a due generazioni non ci sarebbero più guerre nel mondo.
Non esiste un dono analogo da parte degli stoici. Marco Aurelio, Epitteto, Seneca ci hanno lasciati idee, spunti e anche esercizi spirituali. Non c'è un analogo stoico della meditazione. E' difficile capire perchè. Forse è mancata negli stoici la vocazione profonda di Siddharta di salvare l'umanità. E non è davvero cosa da poco, rimanere 40 giorni sotto un albero giorno e notte, senza mangiare, per capire come salvare l'umanità dalla sofferenza. Forse nessuno dei grandi stoici aveva una passione così grande per la salvezza dell'umanità. Forse non c'è stata una tradizione successiva che è riuscita a codificare e perfezionare gli esercizi spirituali e trasformarli in pratiche percorribili e misurabili. Questo è invece è accaduto nel buddismo. Per secoli e millenni i monaci buddisti partendo dalle tradizioni orali che riportavano gli insegnamenti del Buddha hanno perfezionato le pratiche e gli esercizi e oggi dopo millenni disponiamo di pratiche perfettamente codificate, testate per secoli, insegnate e praticate regolarmente da milioni di persone. Tutto questo manca nello stoicismo, e ancora oggi, la maggior parte di chi propone e rilancia lo stoicismo e la corrispondente importanza della pratica rispetto alla teoria poi non dispone di strumenti chiari, codificati e perfezionati per diventare realmente uno stoico e farne una disciplina percorribile. Come si diventa stoici, insomma, è ancora un dilemma. Perchè è certo che non si diventa stoici leggendo libri. Occorre pratica, ma quale pratica? Basta il diario dello stoico o la meditatio malorum? Come si misurano gli avanzamenti, quali esercizi servono in quali specifiche situazioni? Dovrebbe essere questo il cruccio degli stoici contemporanei: codificare pratiche, esercizi che permettono di coltivare le virtù stoiche e misurare gli avanzamenti dei praticanti, organizzare ritiri, scuole accademie dove si insegnano le virtù, non le teorie. Altrimenti siamo daccapo. Purtroppo questo è un lavoro molto ingrato durissimo e che richiede decenni per capire se viene fatto correttamente, ma sarebbe l'unico modo per restituire agli stoici il valore che essi hanno cercato di generare e per cogliere veramente e finalmente l'occasione del loro insegnamento.
Per queste ragioni ritengo infine che lo stoicismo sia da approfondire e per quanto possibile integrare nella propria al netto dei problemi di cui ho parlato, fermo restando che esso da solo non è sufficiente per una crescita personale e spirituale.


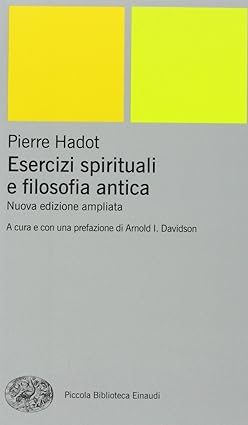
Commenti