Cambiare lavoro, trasformare la propria vita oppure essere resilienti
- Pierluigi Casolari
- 1 feb 2024
- Tempo di lettura: 5 min
Può succedere che dopo avere fatto un percorso professionale per molti anni ci si renda conto che tale carriera non ha niente a che fare con noi. Oppure non ha più a che vedere con quello che siamo diventati e che siamo in questo momento. Ci chiediamo allora se è stato solo frutto del caso (ho risposto ad un annuncio, ho fatto un corso), dopo magari esserci autoconvinti per anni che invece era proprio quello che volevamo.
Nel corso degli anni quello che all'inizio sembrava una scelta un po' avventata, poi diventa parte integrante della nostra vita e del nostro tentativo di giustificarla. E così ci troviamo imprigionati non solo in lavori che non ci convincono più, ma anche in spiegazioni e blocchi mentali che ci impediscono di scegliere e vedere realmente quello che ci piace o meno.
Ma che cosa dobbiamo fare quando ci rendiamo conto che un lavoro non ci interessa più? Si potrebbe dire che esistono almeno 3 approcci al cambio di lavoro.
Il primo approccio è quello più semplice. E sostanzialmente recita: non mi piace il contesto lavorativo in cui mi trovo, ragion per cui voglio cercare un'alternativa in un settore simile o in un ruolo simile. Magari proponendomi all'azienda concorrente. In questo approccio in qualche modo viene identificato come problematico il rapporto con il capo, lo stipendio o i benefit aziendali; per cui si sceglie di stare nello stesso settore facendo più o meno lo stesso lavoro, ma in condizioni migliori. Non è in discussione l'insieme dei valori. Ma solo la volontà di migliorare le condizioni, fermo restando valori, passioni e interessi esistenti.
Il secondo approccio è quello resiliente. Ovvero: non mi trovo nel lavoro che svolgo ma dopo avere fatto un percorso personale e interiore, capisco che devo lavorare su di me per essere in grado di accettare maggiormente la realtà, apprezzare ed essere grato per ciò che ho, ridurre i momenti di stress attraverso una vita più sana, concentrarmi su una maggior equilibrio tra vita e lavoro. Cercare insomma in altri ambiti della vita la ricerca di significato, oppure capire che il significato è nel prendere bene quello che capita. Non in un altrove esotico e irraggiungibile.
Il terzo approccio è quello della rivoluzione. Dopo avere capito che quello che faccio non mi rappresenta e dopo avere concluso che non sono nato in questo simpatico mondo per lavorare al computer, compilare fogli excel o fare accordi commerciali e dopo avere infine capito che il tempo è prezioso, limitato e incerto, decido inevitabilmente di cambiare completamente lavoro, spesso anche vita e residenza. Magari trasferendomi in qualche amena località esotica, reinventandomi come nomade digitale, freelance che lavora in smart working, o magari addirittura aprendo un'attività a contatto con la natura, grazie ai soldi della liquidazione.
A queste 3 opzioni corrispondono altrettante tipologie di storie, modelli di comportamento e combinazioni di rischi e opportunità, ciascuno con un'infinità di sfumature.
Il primo approccio è tendenzialmente un approccio pragmatico, razionale e concreto. si basa sun un'analisi delle competenze e degli obiettivi concreti, e si realizza nel decidere che sebbene non ci si trovi particolarmente bene nell'attuale lavoro è sempre possibile fare uno scatto di carriera e superare le difficoltà, cercando altri lavori, puntando sui propri punti di forza. Questo è il modello di comportamento lavorativo classico, quello a cui eravamo abituati fino a poco tempo fa. Quando funziona permette di fare passi avanti nella scalata sociale e di carriera, passetto dopo passetto. Quando non funziona però è spesso perché non si è guardato in profondità, l'ansia e l'insoddisfazione non erano relative al bisogno di uno scatto di crescita, un livello in più, un bonus migliore. Ma nascondevano la mancanza di un senso nella nostra vita. Ma con questo approccio il tema del senso nemmeno lo sfioriamo. Ci si muove ad un livello più superficiale, sempre all'interno dei perimetri di valore dell'economia classica (migliore stipendio, meno capi e più risorse da gestire, più soldi per una casa migliore, etc.
Il secondo approccio è quello che vorrebbero le aziende, che non a caso stanno includendo sempre più frequentemente strumenti e pratiche di benessere per i dipendenti, dallo yoga ai nidi aziendali, dalla mindfulness al ping pong negli spazi comuni. In generale questo è un approccio complesso. Al di là delle aziende che scommettono su questa strategia (fidelizzare invece che assumere continuamente), le persone che provano questo percorso di consolidamento nonostante siano arrivati al punto di capire che il lavoro non li rappresenta più e che non è quello il senso della loro vita devono affrontare una quantità enorme di sfide. Da un lato se non si riesce in questo lavoro di accettazione si rischia di cadere in forme più o meno esplicite di rassegnazione (quiet quitting). Serve infatti una profonda rivoluzione interiore, per arrivare a vedere in una nuova luce, la perdita di significato in ambito lavorativo. Oggi spesso si utilizza la mindfulness proprio per aiutare le persone a stare, vedere, accettare il presente, godendo dei piccoli gesti quotidiani anche al lavoro: il caffè con i colleghi, la bellezza di uscire presto la mattina, prendere la metro e vedere una caleidoscopica umanità, oppure i colori dell'autunno, prefissarsi piccoli obiettivi sul lavoro, fare il proprio dovere con orgoglio. Questo modello è rappresentato magistralmente da Perfect Days, l'ultimo film di Wim Wenders, in cui l'autore rappresenta l'orgoglio e la passione del protagonista nello svolgere con minuziosa attenzione, presenza mentale, meticolosa dedizione il più umile dei lavori. L'altro volto dell'illuminazione però è la rassegnazione, la frustrazione e il girare a vuoto. Il non riuscire a cambiare. Il senso di fallimento, il vivere di rammarichi. Il non cambiare perchè non si ha il coraggio di farlo, mascherato da "mindfulness"
Il terzo approccio è invece forse quello che va per la maggiore - e forse quello che ho preso io. Dopo avere capito che una determinata carriera non rappresenta i nostri valori e ciò che siamo, iniziamo un lungo percorso di trasformazione personale e professionale per poter cambiare settore e tipologia di lavoro: da imprenditore a counselor, da manager a noleggiatore di surf a Tenerife, da analista finanziaria a insegnante di Yoga. E' la via della rivoluzione. O dell'Ikigai per usare un concetto più contemporaneo.
Per esemplificare la storia di tanti: dopo avere capito che la vita davanti al pc e di stress del manager non fa più per noi, grazie ad un percorso di coaching o un ritiro spirituale o un qualche tipo di insight, capiamo che dentro siamo viaggiatori, nomadi e amanti della natura e allora facciamo le valigie e cambiamo vita. La parola chiave di questo approccio è: (ricerca della) felicità.
Una parola importante senza dubbio. La chiave dell'Ikigai, di chi cerca il daemon è la felicità o etimologicamente anche l'eudaimonia, il proprio senso, la propria ragione d'essere. Altra parola importante. Solo a dirla mi scorrono i brividi sulla schiena. Eppure se da un lato la versione di successo di questa strategia è il raggiungimento di una maggiore realizzazione personale un miglioramento esponenziale della propria qualità di vita, l'ombra di questa scelta è la fuga dalla realtà più importante: sé stessi. Fuggo dalla mia infelicità, buttandomi in un'altra impresa, in un'avventura esotica, che magari mi inonderà di emozioni nuove e adrenaliniche per mesi, ma con il rischio che poi ad un certo punto, finita l'adrenalina, mi ritroverò a fare i conti con i miei demoni (non daimon, questa volta), dovendo capire a mie spese che non si può fuggire da sé stessi, dalle proprie insicurezza, fragilità o per dirla con un linguaggio buddista - che su queste cose hanno molto da dire - dal proprio karma.
Ognuno dei 3 approcci presenta un lato di luce, una promessa che se viene mantenuta permette una crescita e un lato di ombra, che può manifestarsi in ogni momento e che porta alla frustrazione e all'infelicità. Compito di un coach potrebbe essere proprio quello di presentare al proprio assistito una panoramica sulle tre vie e gli strumenti e il supporto personale per affrontarli.


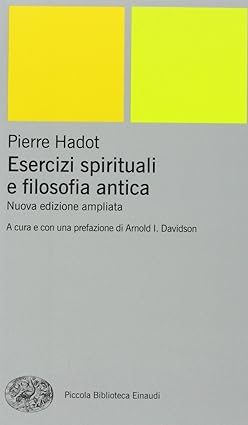
Commenti